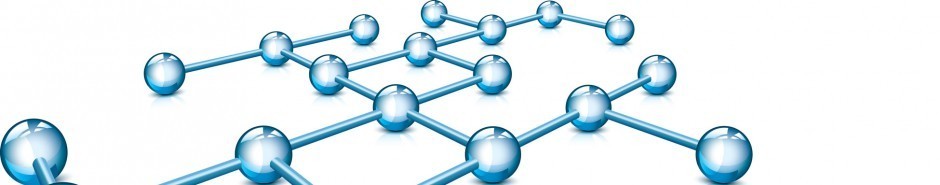“A voce alta”
di a.p. – 5 Giugno, 2006
“A voce alta” Stasera andrà in onda su Rai 1 “A Voce Alta”, una storia vera, quella di un sindacalista dei Cantieri Navali di Palermo, che ha avuto il coraggio di denunciare le grosse irregolarità e il giro di estorsioni che ostacolavano ed alteravano il normale svolgimento delle opere. Nei giorni scorsi il protagonista ha dichiarato alla stampa di essere ancora in lotta per la verità, e di affidarsi ai giornali per tutelare la sua incolumità dopo le denunzie sporte. Purtroppo dispiace dovere rilevare che, quando è un onesto cittadino a denunciare, l’ingranaggio prefettizio, e degli organi preposti al controllo, si inceppa in lungaggini burocratiche che, troppo spesso, tardano l’assegnazione delle misure di tutela e prevenzione del rischio con l’autorizzazione alla scorta.
tratto dal blog http://www.la-tua-voce.it – archivio – 5/06/2006
Diversamente, si ha modo di riscontrare un intervento più tempestivo nei confronti dei pentiti, altrettanto utili alle indagini, e più celermente inseriti nei programmi di protezione. Invece occorrerebbe richiamare l’attenzione degli organi giudiziari, di tutte le forze dell’ordine, e delle pubbliche amministrazioni, proprio su quei cittadini onesti che si fanno carico consapevolmente dei rischi che comporta una denuncia a viso aperto contro l’illecito ed il sistema estorsivo diffuso. In merito a questo grave stato dei fatti, riporto di seguito il frutto di un’intervista rilasciatami da un imprenditore palermitano, che, da solo, ha lottato per più di vent’anni contro il sistema affaristico mafioso, che ha coperto, e continua a coprire, con la sua coltre di compiacenze la Sicilia della prima e della seconda Repubblica, deviando il corso di un’imprenditoria troppe volte asservita al compromesso e al malaffare. L’imprenditore, oggi, ha affidato nuovamente la sua vicenda alle indagini della magistratura, e, attualmente, è ancora in attesa dell’intervento richiesto alla Prefettura di Palermo per la tutela della sua vita e dei suoi familiari. Nel frattempo, anche lui, si rivolge a tutti gli organi di stampa disposti a dare voce a chi, onestamente, decide di inoltrarsi lungo il pericoloso, ma doveroso, percorso della denuncia e del diniego all’estorsione e all’intimidazione. Potrebbe essere un’utile chiave di lettura l’emblematico passo, tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia “Il Giorno della Civetta”, che ci consente di assistere ad un verosimile dialogo intrattenuto tra un prefetto, un questore, e un maggiore, o un colonnello delle forze dell’ordine, appena arrivato in Sicilia, e suggerisce una giusta chiave di lettura per comprendere quanto di seguito sarà esposto. “…– Voi ci credete alla mafia? – Ecco…- E voi? – Non ci credo. – Bravissimo. Noi due siciliani, alla mafia non ci crediamo: questo a voi che a quanto pare ci credete, dovrebbe dire qualcosa. Ma vi capisco: non siete siciliano, e i pregiudizi sono duri a morire. Col tempo vi convincerete che è tutta una montatura…” Come in un reality show antesignano, in quelle pagine la mafia appariva in tutta la sua complessa rete di rapporti affaristici-imprenditoriali, che si snodavano nei salotti borghesi della politica siciliana, in un set i cui protagonisti si atteggiavano ad inconsapevoli pedine mosse da un sistema la cui pericolosità veniva, paradossalmente, compresa e individuata solo lontano dai confini siciliani. La mafia “c’è” per chi la vuol vedere. Lo slogan è sempre attuale oggi in Sicilia. Come nelle pagine di Sciascia, la mafia, se c’era, non c’è più, specie per chi ci convive, e la determina con fatti e articolate connivenze, ritenendola un folklore da souvenir con tanto di coppola e lupara; quando, all’inverosimile, poi c’è chi non la vede, e, irritandosi quel poco di coscienza rimasta, non ne vuol neanche sentire parlare.
C’è un Paese chiamato Italia, come leggiamo in un efficace articolo di Gianni Barbacetto “L’isola azzurra-Totò, Peppino e La Malapolitica” (www.diario.it), dove c’è un’isola dei padrini, in cui la verità si perde nei fondali blu notte delle sue coste, e delle isole minori che le fanno da corollario, splendido ma terribile, in cui la connivenza con l’illecito, all’ombra del lecito, si annida in un territorio che dovrebbe vivere solo di turismo e di calorosa accoglienza. C’è poi un’isola che si chiama Ustica, che purtroppo è ricordata per la misteriosa sciagura aerea dell’estate 1980, e che cela ancora tanti altri segreti, come quello di una triste vicenda che si avvinghia alle sorti di un imprenditore locale che, dopo più di un ventennio, è ancora sotto il giogo di un fallimento anomalo, ancorché, ad oggi, inspiegabilmente aperto, presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Palermo. Della vicenda è stata resa nota parte dell’intrigata trama di interessi economici, politici e di potere, nell’articolo, firmato da Francesco Viviano ne “La Repubblica” inserto Palermo del 20/01/06, dal titolo inquietante almeno quanto la storia di cui si parla “L’Hotel fantasma di Ustica”. L’articolo riporta la denuncia dell’imprenditore palermitano Baldassare Bonura che, dopo venticinque anni, chiede ancora giustizia per il danno e la beffa di un fallimento non giustificato dalle carte e dai fatti documentati, cui si è opposto con una serie di esposti-denunzie presso la Procura di Palermo e di Caltanissetta, dove sono in corso le indagini essendo stato riconosciuto come parte offesa.
L’Hotel San Bartolomeo, categoria quatto stelle, nel cuore dell’isola dei sub, che fu edificato su un terreno ereditato dall’imprenditore dalla zia nobil donna Anna Notarbartolo di Sciara sindaco di Ustica per tre lustri, che aveva una capienza di 120 posti letto, l’unico con due ascensori e due ristoranti, e il primo, vent’anni fa, con pannelli solari, “era in regola”, come dichiarato nell’articolo. Eppure la costruzione venne bloccata in quanto ritenuta “abusiva” dall’allora sindaco Vito Ailara, la cui madre era proprietaria della “Pensione Clelia” con vista panoramica sul mare, almeno fino a quando questa non fu ostruita, però, dall’edificio alberghiero dell’imprenditore. Nonostante il bene placito della Sovrintendenza di Palermo, dei Vigili del Fuoco, nonostante la licenza per attività turistico-alberghiera, ed il parere positivo di una perizia tecnica eseguita sull’immobile da un architetto, incaricato dalla stessa amministrazione comunale, l’imprenditore si vide negato il certificato di abitabilità. Anzi, come sottolineato dal Bonura, fu proprio il sindaco che, con un eccesso di zelo, andò oltre le sue competenze, e spedì di suo pugno il diniego alla BNL presso cui erano già state istruite positivamente le pratiche per il finanziamento alberghiero della “ Giovanni Bonura e figli” sas, che così furono congelate, con l’esito che le somme stanziate dalla BNL e anticipate dalla Sicilcassa, pari a circa un miliardo e mezzo di lire, per opera turistico-alberghiera di pubblico interesse, andarono perdute anche dall’istituto di credito. Che dire, di necessità si fece virtù: l’albergo, dopo due stagioni, e gran successo di pubblico, attestato dai giornali siciliani, fu chiuso con ordinanza dell’allora giudice delegato Giuseppe Barcellona per esecuzione dell’istanza di fallimento; poi si accertò che la perizia comprovante la regolarità dell’immobile era sparita dagli uffici comunali, e che l’incartamento della società di gestione del San Bartolomeo si trovò, stranamente, inserito, forse erroneamente, nel fascicolo della società alberghiera proprietaria. Il risultato fu la chiusura senza appello, nonostante le reiterate denunce puntualmente archiviate, di un albergo funzionante, con arredi del Basile, e clientela d’elite messa alle porte con valige a carico. Si raggiunse il limite quando il giudice chiese all’imprenditore, noncurante della clientela testimone, di “andare a pulire le cucine”!! Dal 1984 l’Hotel San Bartolomeo è chiuso; la curatela non lo ha mai gestito, lasciandolo alla mercè degli umori delle amministrazioni comunali che da sinistra a destra via, via si sono succedute. E non si capisce, ad oggi, quale sarà il suo destino, visto che, da una parte è reclamato dal Comune che lo reclama in quanto acquisito al patrimonio pubblico con una sentenza del Tar siciliano “ visto che non fu data esecuzione all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo”; dall’altra ci sarebbe un acquirente che, a detta dell’imprenditore, “sarebbe prestanome di un capomafia di Carini, che profittando del mio stato di decozione ha utilizzato i documenti dei miei procedimenti, aggiudicandosi all’asta fallimentare l’albergo al prezzo vile di 450 mila euro”. La vicenda si fa ancor più sconcertante quando l’imprenditore dice di essere stato costretto a revocare il mandato al proprio legale avvocato Giovanna Livreri, che intanto, non lo aveva informato circa la nuova archiviazione, a firma dell’allora Procuratore aggiunto Bianco, che ancora una volta chiudeva le indagini sull’ultima denuncia presentata presso la Procura di Palermo. Si paventa pure a carico della professionista l’ipotesi grave di “infedele patrocinio”, dopo che l’imprenditore ha saputo, in base all’esame di fatture relative ad una consulenza svolta dallo stesso avvocato Livreri per l’acquisizione del bene di Ustica, mettendo i suoi fascicoli a disposizione di terzi, oggi acquirenti dell’Hotel, in dispregio al diritto di riservatezza dettato dal codice deontologico professionale. Il Bonura, inoltre, ha denunciato anche magistrati e altri soggetti, tra cui consulenti della ex Sicilcassa, amministratori comunali, curatela fallimentare, un architetto, un professore universitario ed un gruppo imprenditoriale, che “avrebbero procurato la svendita dell’albergo presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Palermo”. Adesso l’imprenditore fallito, temendo per la propria incolumità e quella dei familiari, ha prodotto denunzia anche al Prefetto di Palermo Giosuè Marino, e ha depositato presso gli studi di legali e notai di propria fiducia documenti e nastri registrati comprovanti il disegno estorsivo ordito a suo carico. La storia, giornalisticamente parlando, era troppo ghiotta per non destare l’interesse di chi scrive. E che, in questi ultimi mesi, ha raccolto nuove dichiarazioni dell’imprenditore nel corso di un’intervista, da cui è emersa una vicenda, senz’altro personale e, purtroppo, non rara in Sicilia, ma che è lo spaccato del ventennio della Prima Repubblica siciliana, in cui la fecero da padroni la Dc e il Pc, insieme a sedicenti imprenditori di sinistra, che, all’ombra di una tessera rossa non disdegnavano di fare affari con politici limiani e antesignani, pure, della futura Casa delle Libertà isolana. Nome di spicco nella vicenda sin qui narrata, come già pubblicato sull’articolo di Repubblica, è quello dell’ingegnere Giuseppe Montalbano, che nel 1983/84 faceva affari nel settore dell’impiantistica dalle parcelle milionarie, come quella presentata al Bonura per un totale di 800 milioni di un ventennio fa. Oggi il Montalbano, che dice di essere di sinistra, ma che era assistito legalmente dall’amico avvocato Girolamo Bongiorno, papà dell’attuale onorevole Giulia militante in Alleanza Nazionale e genero del giudice Barcellona della Sezione Fallimentare, e che era in affari con l’imprenditore Merra genero dell’onorevole forzista Miccichè, è noto alle cronache perché condannato nel 2002, in primo grado, presso la Procura di Sciacca, per “concorso esterno in associazione mafiosa”, e perchè ritenuto dalla Sezione di Prevenzione come “soggetto socialmente pericoloso” e, perciò, costretto a soggiorno obbligato presso un agriturismo intestato alla moglie. Un altro capitolo fondamentale, per la comprensione della storia, è l’inchiesta svolta dal giudice Paolo Borsellino, che nel 1982 fece rinviare a giudizio l’allora sindaco di Ustica Ailara per aver sostenuto l’abusivismo dell’immobile, contraddicendo i documenti che, invece, ne attestavano la regolarità. Quel processo, però, terminò con l’assoluzione del primo cittadino e del tecnico comunale per “insufficienza di prove”, dando il via ad istruttorie aperte e subito chiuse, e a denunzie di estremi di reato non supportate da doverosi accertamenti. E’ interessante, forse, accostare alle indagini svolte dal giudice Borsellino, l’inchiesta che anche l’amico e collega giudice Falcone aprì nei confronti di Montalbano padre e del suo primogenito, come si legge nell’articolo di Giacomo Papi “ Un giorno con Montalbano” pubblicato su diario.it il 22/02/02. Dall’articolo si ha notizia del fratellastro dell’ingegnere, Giuseppe Ruggiero, che sparì misteriosamente nel 1949, a 27 anni. Leggiamo: “Era amico di Renato Guttuso, Pietro Consagra e Andrea Camilleri. «Lupara bianca», si dice. Dopo la scomparsa, l’ingegnere, allora quattordicenne, fu mandato dal padre nel Lazio. Da Giuseppe Ruggiero, i Montalbano ereditarono 70 milioni dell’epoca. Montalbano padre fu membro della Costituente, sottosegretario alla Marina mercantile nel 1944 e sindaco di Santa Margherita Belice. Difensore del movimento bracciantile siciliano, resta una figura di riferimento per chi in Sicilia combatte la mafia…Morì a 94 anni, nel 1991. Un’esistenza senza ombre?” Otto anni prima della morte del vecchio Montalbano, scrive Papi, il giudice Giovanni Falcone iniziò a occuparsi del suo primogenito. Nel provvedimento di confisca firmato dal giudice Cardinale, in un passaggio sui rapporti dell’ingegnere con «l’associato mafioso» Giuseppe Lipari, si legge: «A causa di tali rapporti già nel 1984 il Montalbano e il genitore professor Giuseppe Montalbano avevano ricevuto una comunicazione giudiziaria quali indagati di associazione mafiosa». Ma anche l’inchiesta del giudice Falcone nel 1987 fu archiviata. Sei anni dopo, nel 1993, dopo la rappresaglia stragista, fu arrestato Totò Riina. Ricordiamo pure che il boss corleonese latitante trovò residenza nella lussuosa villa di Via Bernini, a Palermo, intestata all’ingegnere Giuseppe Montalbano. Ritornando all’intervista con l’imprenditore Bonura, ad una lettura attenta dei fascicoli della sua lunga storia, esisterebbero segnalazioni e denunzie, pertinenti ai fatti sin qui ricordati, sporti alla Procura della Repubblica di Palermo che, ancora oggi, dopo circa un ventennio, rimangono, però, inspiegabilmente, sepolte sotto i tanti incartamenti.
Inchieste aperte e subito archiviate, che se fossero state lette con meno superficialità, probabilmente, avrebbero potuto accelerare le indagini sui nomi eccellenti della società palermitana, sui “colletti bianchi”, già classificati da Falcone e Borsellino, collegati ad ambienti di malaffare da una parte, e, dall’altra protagonisti del mondo politico della Prima Repubblica in modo trasversale. Alla luce di quanto documenterebbe la denuncia del Bonura, risalente al lontano 1985, nasce quindi l’urgenza di capire se i boss dei boss davvero non potevano essere scovati molto prima, forse, in un tempo in cui si sarebbe potuto far luce sulla miscela esplosiva di interessi tra mafia, politica e imprenditoria che verosimilmente esitò, appena dieci anni dopo, nelle stragi del 1992. Nell’indagine svolta dal GI.CO. di Palermo nel 1993, racconta il Bonura, con riferimento a quanto già denunciato nel 1985 per il fatto estorsivo subito, tra le vicende e gli elementi indiziari riguardanti l’ingegnere Montalbano vengono riportate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Baldassare Di Maggio che indica l’ingegnere come “prestanome” del patrimonio di Riina, che durante la latitanza poi trovò domicilio proprio nella villa a lui intestata. L’inchiesta fu archiviata dal Procuratore aggiunto Giuseppe Pignatone.
Nel 1985 insieme agli spunti investigativi del fascicolo, fu pure consegnato al procuratore Pignatone un nastro, sino ad oggi rimasto sigillato presso gli uffici della Procura di Palermo, su cui era registrata una conversazione telefonica trascritta dal GI.CO. e mai contestata sino al 1994 dalla Procura al medesimo ingegnere. Eppure dalla conversazione telefonica, aggiunge il Bonura “si evinceva chiaramente che il Montalbano, essendo al corrente delle determinazioni sia della direzione della Cassa di Risparmio sia dei giudici della Sezione Fallimentare di Palermo, mi dava un ultimatum, cercando di estorcermi la quota di maggioranza dell’ albergo, che poi fu dichiarato fallito non essendomi piegato all’estorsione”. Sembrerebbe che l’ingegnere avesse facilità d’accesso alle determinazioni della sezione fallimentare grazie a rapporti amicali intrattenuti per mezzo di suoi legali, tra cui l’avvocato Girolamo Buongiorno, a loro volta imparentati con gli stessi giudici fallimentari. Tutto ciò sarebbe chiarito dalla registrazione telefonica in cui si fa riferimento ad incontri preliminari all’eventuale accordo per evitare il fallimento, da tenersi presso lo studio dell’avvocato Bongiorno cognato del giudice Giuseppe Barcellona: tutto ciò portò alla ricusazione del giudice, che poi rivestirà il ruolo di Procuratore Generale a Caltanissetta. Per quanto riguarda i rapporti tra l’ingegnere e le banche, in merito alla Cassa di Risparmio, oggi assorbita dal Banco di Sicilia, sono in corso dall’ottobre 2005 le indagini per bancarotta e distrazione a carico di quattro ex direttori degli anni ’90, per un crac di 4 mila miliardi di lire e per un finanziamento di 20 miliardi di lire alla famiglia Graci di Catania. Ma lo stesso imprenditore taglieggiato, già nell’85, aveva denunciato i gravi comportamenti illeciti della C.C.R.V.E in concorso con lo stesso ingegnere Montalbano. Che il Montalbano gravitasse tra affari e interessi per niente limpidi, oggi è dimostrato, in modo inequivocabile, dalla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, arrivata solo nel 2002. E’ perciò interessante scorrere il fascicolo del GI.CO. dove si legge che già in un interrogatorio del 1993, cui fu sottoposto il Di Maggio, questi dichiarò che “…subito dopo la morte di Inzerillo Salvatore, si recò a Monreale con Brusca Giovanni in un villino in zona Aquino abitato, secondo Brusca, da Riina Salvatore”. Di Maggio, secondo il verbale di deposizione, affermò di ricordare che quel villino era intestato a tale ingegnere Montalbano su espressa richiesta di Lipari Giuseppe. Infine è lo stesso Brusca che afferma di ricordare “ di aver detto a Di Maggio che l’ingegnere risultava intestatario anche di altri beni in realtà appartenenti a Riina”. Quanto qui riportato sembrerebbe inserirsi in un’analisi più complessa, che vede arrivare Montalbano, non certo casualmente, lungo lo snodo politico imprenditoriale della provincia palermitana e trapanese, al centro di incroci pericolosi con mafiosi del calibro di Riina (“capo dei capi” su cui grava il regime del 41 bis e indicato come responsabile della decisione degli attentati contro Falcone e Borsellino), Brusca (oggi collaboratore di giustizia nella cui disponibilità sono stati trovati due telecomandi riconducibili al progetto di un attentato contro il Procuratore Grasso, e la DIA indaga sulla possibilità che la mafia ne fosse già in possesso prima dell’attentato di Via D’Amelio), Lipari (geometra dell’ANAS oggi anche lui indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e come prestanome di beni mafiosi); si tratterebbe cioè di quel braccio criminale che siglò col sangue di troppi uomini onesti una fase in cui la mafia si fece ancor più violenta, sino alla decisione estrema delle stragi. Nel 1995 in merito al contratto di locazione di via Bernini 52/54, i P.M. G. Pignatone, R. Scarpinato, V. Teresi ritennero di dovere archiviare l’inchiesta nei confronti del Montalbano attestando che “il solo fatto che Riina abitasse in una villa di una società facente capo a Montalbano non fosse sufficiente a dimostrarne la responsabilità”; a sostegno di tale richiesta di archiviazione i P.M. citarono le comprovate modalità di legge con cui la villa venne data in locazione al sig. “Bellomo”, sotto il cui cognome si celava l’identità di Salvatore Riina. L’ingegnere, poi, nel 1999, sarà arrestato per la presenza di Salvatore Di Gangi nel complesso alberghiero di sua proprietà “Torre Makauda”, a Sciacca: anche in questo caso comunque l’accusa cadde perché, secondo la Procura, nel periodo in cui il mafioso fu ospite di Montalbano “non era latitante”, ergo l’ingegnere non ne protesse la latitanza. Ancora un nome eccellente ci riporta al Montalbano, quello di Pino Lipari, il geometra della mafia, già citato da Di Maggio, anche lui, casualmente, inquilino in comodato d’uso, di un appartamento di Via Aquileia a Palermo sempre nell’annovero delle proprietà dell’ingegnere imprenditore, che ancora una volta si è dichiarato del tutto estraneo al soggetto e di non saper nulla degli affari curati dal suo inquilino. Insomma, sembrerebbero tutte casualità, a detta dell’ingegnere, che si sono accanite su un sedicente rappresentante del PC, che sempre solo per caso, e per lavoro, lambiva il giro milionario degli appalti pilotati da Antonio Alfano, un ex amministratore comunista arrestato a Palermo con l’accusa di associazione mafiosa; e che, sempre a suo dire “ha avuto la sola colpa di essere imprenditore”, sorvolando sulla titolarità di beni per 400 miliardi delle vecchie lire. Eppure queste proprietà sono state confiscate a Montalbano, a seguito dell’unica condanna a sette anni e mezzo comminatagli dalla Procura di Sciacca nel 2002, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa; le proprietà e le quote societarie sono state ricondotte a Riina, come aveva dichiarato Di Maggio e come venne riportato nel fascicolo del GI.CO., in merito alla vicenda del Bonura, di cui si è detto, archiviato su richiesta dei P.M. E. La Neve e del Procuratore della Repubblica Aggiunto V. Aliquò. C’è da chiedersi, se sia stato ancora solo il caso a volere che, nel giugno 2005, il patrimonio sequestrato a Montalbano gli sia stato riassegnato con la sentenza di un giudice, trasferito dalla Sezione Fallimentare alla Corte d’Appello di Palermo- sezione misure di prevenzione. Tra i beni dissequestrati, amministrati nel frattempo da Alberto Stagno D’Alcontres, professore di Diritto commerciale all’Università di Palermo. fratello di Francesco deputato di Forza Italia, si enumerano pure il complesso “Torre Makauda” e la società di gestione; un patrimonio di circa 250 milioni di euro a fronte della pur riconosciuta pericolosità dell’imputato. A tal proposito, il Bonura non comprende la spiegazione di un siffatto patrimonio, visto che quando conobbe l’ingegnere, per affidargli il lavoro di impiantistica dell’albergo, non ne conosceva grandi capacità economiche, anzi, a suo dire “ le difficoltà economiche attraversate nella costruzione del complesso alberghiero “Makauda”, gli venivano di volte in volta sanate dall’intervento dell’ingegenere Mineo, consulente, in quegli anni, della Cassa di Risparmio e del Banco di Sicilia Alla luce di questi fatti, all’apparenza contraddittori, c’è da chiedersi, allora, se ci siano stati particolari motivi, già nell’85, perché alcuni giudici non ritenessero interessante la denuncia sporta contro Montalbano e altri soggetti; e perchè il dott. Pignatone non ritenne opportuno almeno ascoltare la registrazione del fatto estorsivo su ricordato e approfondire le indagini sui fatti denunciati. Forse, venti anni fa, si sarebbero potuti, almeno, tenere d’occhio quelli che erano solo i primi passi mossi da un gruppo di affaristi in erba, che dietro la trasversale militanza politica, tessevano rapporti che nulla avevano a che fare con il pubblico interesse. Vero è che si andava verso gli anni più discussi e contraddittori della Procura di Palermo, di cui alcuni fatti furono resi noti nel giugno 1992, subito dopo la strage di Capaci, dall’Espresso e da La Repubblica, che pubblicarono alcuni episodi che Falcone avrebbe raccolto nel suo diario. Si tratta della cronaca dettagliata degli ultimi mesi di Falcone al Palazzo di Giustizia di Palermo e dei suoi contrasti con il Procuratore capo Giammanco. Il senatore socialista Maurizio Calvi, stando alla cronaca, ex vicepresidente della commissione antimafia, in quei giorni confermava l’esistenza dei diari di Falcone, e inoltre affermava che Falcone durante un viaggio a Vienna gli parlò dell’intreccio a Palermo tra la mafia e pezzi importanti delle istituzioni, nel senso che Falcone non si sarebbe fidato in alcun modo né della questura di Palermo, né del Comando dei Carabinieri di Palermo, né tanto meno di alcuni personaggi importanti della Prefettura di Palermo. Tutto ciò fu poi confermato dall‘amico Borsellino.
Il magistrato conferma l’autenticità dei diari di Falcone pubblicati dal Sole 24 Ore, il 24 giugno 1992 in un articolo a firma di Liana Milella, e dà ragione a Caponnetto: “Falcone cominciò a morire nel 1988, anche se con ciò non intendo dire che la strage sia stata il naturale epilogo di questo processo di morte…Oggi tutti ci rendiamo conto di quale sia stata la statura di quest’uomo e ci accorgiamo come il paese, lo Stato, la magistratura, che forse ha più colpe di chiunque altro, cominciarono a farlo morire proprio nel gennaio ’88…”. Gioacchino Natoli, collega di Falcone, nel corso della riunione svoltasi nell’aula magna del Palazzo di Giustizia in ricordo della strage di Capaci, ha ricordato che il pool antimafia fu smantellato subito dopo la nomina di Antonio Meli, proprio nel 19 gennaio 1988, quando il CSM lo elesse al posto di Falcone nel ruolo di consigliere istruttore; nel corso della riunione in ricordo della strage del 1992 il giudice Natoli “sente la pressione di un clima insopportabile“, come da lui evidenziato. Così, a scanso di retoriche frasi di circostanza, interviene con parole che, riportate da La Repubblica inserto Palermo del 24/05/06, è bene qui sottolineare: “Falcone oggi ci avrebbe sputato addosso se avesse visto tutto questo…dobbiamo avere il coraggio di dire le cose come stanno: Giovanni Falcone era un uomo osteggiato da molti, anche e soprattutto in questo Palazzo, in cui c’era chi diceva ai giovani uditori che esisteva un metodo Falcone, che consisteva nel prendersi i fascicoli che si voleva. Quando si insediò Antonio Meli e gli tolse i fascicoli, qui rimanemmo in tre: io, Leonardo Guarnotta e Ignazio De Francisci, quando Borsellino dovette andare a Marsala, e compredemmo che Falcone rischiva di rimanere solo come un cane.“ Molti di quei fascicoli, continua il Bonura, giacciono sugli scaffali polverosi, dentro uffici dietro porte chiuse, sulle quali, ora, bisogna bussare, e se occorre, picchiare forte per farsi sentire e per non lasciare mai più soli giudici ed inquirenti, ai quali la società civile e onesta, fuori dal Palazzo, ha il dovere di far saper di essere presente, di saper leggere e di essere pronta ad un radicale cambiamento politico e d‘opinione. Nell’era del digitale l’arma efficace contro il silenzio complice di rinvii e scadenze dei termini, contro i dubbi, i fraintendimenti e le lungaggini burocratiche, che troppe volte hanno annebbiato e deviato il corso delle indagini, è leggere e diffondere nel web fonti e documenti, fatti e denunzie che tengano desta l’attenzione di chi già sa, e che interessino chi per un fatto generazionale vuole sapere, anche a rischio di infastidire chi, intanto, volge altrove lo sguardo, sperando che la storia lo segua, raccontandosi di avere ragione. La vicenda dell’imprenditore taglieggiato, dell’albergo negato, del fallimento ventennale e alquanto anomalo, si comincia a comprendere se letta nell’arco del decennio 1980/90, l’epoca del maxiprocesso e dell’inizio di mani pulite. Allora leggiamo, e riportiamo alla memoria l’ordinanza- sentenza che In Nome del Popolo taliano venne emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale contro Abbate Govanni+706, depositata nella cancelleria in data 8 Novembre 1985 . All’istruttoria presero parte, per delega conferita a norma dell’art, 17 R,D, 28.5.1931 n.603, i Giudici Istruttori Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello Finuoli. Il testo che riporta la sentenza è Mafia-L’atto d’accusa dei giudici di Palermo-a cura di Corrado Stajano per la Editori Riuniti edito nel gennaio 1986. I giudici che lavorarono per anni a questa sentenza lottarono contro la mafia, e contro i poteri forti; come si legge, furono, soli lungo il corso del loro operato, esposti non solo a grandi rischi, ma anche alle mine del sospetto, della diffidenza e della paura. Dopo quaranta volumi e 8.607 pagine, la sentenza portò a termine l’istruttoria che più di tre anni prima era stata iniziata dal Consigliere Istruttore Rocco Chinnici che profuse il suo impegno civile a prezzo della sua stessa vita. La sentenza di cui si tratta è la trama di un romanzo nero che rattrappisce le ossa e gela il sangue, come Stajano sottolinea nell’introduzione, un cumulo stratificato di realtà mostruose che riguardano l’intero paese dagli ultimi anni settanta sino alla metà degli ottanta. Dal primo collaboratore di mafia Leonardo Vitale, nel 1973, che si cercò di far passare per un esaltato, alla rete segreta di Cosa Nostra e dei suoi uomini d’onore; da Buscetta al sistema di famiglie, mandamenti e commissioni; dalle stragi annunziate da Di Cristina alle inquietanti protezioni politiche; dall’affare Sindona ai traffici tra le famiglie di Catania e quelle di Palermo in nuovi rapporti di prossimità e collaborazione; dai traffici internazionali di eroina del capo cinese del Triangolo d‘Oro ai mercati d’Occidente e di Cosa Nostra passando per la Svizzera; dall’omicidio Dalla Chiesa alla collusione tra mafia, Cavalieri del lavoro e politici; dai Salvo allo scandalo delle esattorie, dell’aggio miliardario (10% sulle imposte) e del sistema clientelare. Dalla sentenza dei giudici risultò allora quello che, come oggi, la coscienza collettiva ben sapeva: Riina e Provenzano, il rivoluzionario e il moderato, nello scenario di sanguinose faide familiari, si spartivano la Sicilia e i traffici che travalicavano i confini isolani, transitando per le vie della politica e degli affari d’oro sino alla scalata dei Corleonesi e al “sacco di Palermo“, il tesoro di don Vito Ciancimino che oggi è materia di indagine. Dunque già ventanni fa Borsellino e Falcone, con i pochi colleghi di cui si fidavano, avevano delineato il terzo livello dei reati di mafia: le collusioni dei padrini con il mondo economico, con i colletti bianchi, al sicuro sotto le protezioni politiche, realtà che oggi sono confermate da sentenze già emesse, da indagini in corso, da indizi probatori inequivocaboli, e dalle dichiarazioni dell’attuale Procuratore Capo Nazionale Pietro Grasso. Urge allora indagare e insistere in quella direzione, come lo stesso Tenente Carmelo Canale ha ultimamente sottolineato, ascoltato dalla Procura di Caltanissetta, asserendo non solo che ancora i mandanti della stragi del 1992 non sono stati individuati, ma che il giudice Borsellino collegava in qualche modo l’attentato a Falcone alle indagini in corso su mafia e appalti. I tempi sono maturi, forse, per cercare i mandanti lì dove, dietro le porte dei salotti buoni, e degli studi professionali, un pugno di uomini decide, forte delle coperture compiacenti, le sorti della Sicilia e della sua economia. Oggi stando ai fatti questa potrebbe essere la pista da seguire, specie se si tiene in considerazione la mole d’indagini, ed i conseguenti sequestri di tutte le aziende inserite nel giro d’affari che la mafia ha gestito nel settore degli appalti e dei subappalti, mediante l’infiltrazione nei cantieri e con il gioco dei ribassi illegali. Dunque il cerchio sembra stringersi proprio attorno alla questione morale sollevata dal Commissario Capo Manfredi Borsellino, figlio del compianto giudice, che, nella lettera del 2005 inviata alle testate giornalistiche nazionali, ha richiamato l’attenzione sulla “holding dell’antimafia” dei salotti buoni di Palermo. Ossia in quel reticolo amicale e clientelare tra politici, avvocati, commercialisti, aziende e imprenditori di grosse catene di distribuzione commerciale, consorzi, e, forse, anche soggetti in contatto con logge massoniche: un multiforme connubio di interessi che sembra ripercorrere la via battuta da imprenditori come il Montalbano, forse collegandosi ancora oggi a lui, e che influenza l’economia isolana con modalità che sembrano non proprio limpide, oltrepassando troppe volte i confini della vera e propria collusione mafiosa.